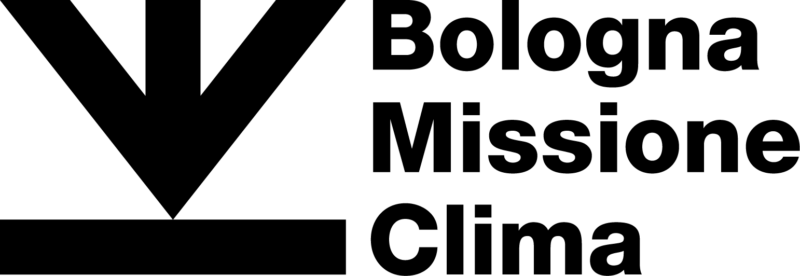Le città moderne – sempre più arroventate dalle ondate di calore – hanno l’urgenza di disseminare il proprio tessuto urbano di spazi verdi. Sono rifugi climatici per i cittadini, e non solo.
Il problema: troppo cemento
Di base c’è il fatto che le città non sono state progettate prevedendo l’aumento medio di temperature dovute alla crisi climatica. Questo significa concretamente che gli spazi urbani sono estese superfici artificiali fatte di materiali che si scaldano molto sotto il sole e che disperdono lentamente il calore. Di giorno, dunque, le città sono una spugna per il calore e di notte sono ancora molto calde rispetto alle zone rurali. Il fenomeno aumenta l’intensificarsi delle isole diurne di calore urbano – con gravi ripercussioni sulla salute soprattutto dei più fragili – e al calar del sole incrementa le cosiddette “notti tropicali”, ossia quelle con temperatura superiore ai 20 gradi (in Italia Bologna è la città più colpita).
La soluzione: aumentare il verde
L’ ambiente urbano per rigenererarsi deve dunque per forza aumentare le sue superfici naturali. Molte comunità hanno reso così i parchi e le zone naturali, centrali nel loro racconto pubblico e fondamentali nel loro rapporto coi cittadini. L’ultimo esempio di questa prospettiva è quello di Vilnius, diventata per il 2025 Capitale Verde Europea anche in virtù del fatto che il 65% della sua superficie è verde o adibita a parco. La capitale della Lituania ha incentrato la propria narrazione sul verde pubblico e promuove la cosiddetta Green Wave, una politica che mira a piantare oltre 100mila nuovi alberi e 10 milioni di arbusti quest’anno. Il Comune dona piante e fornisce consulenza ai cittadini per rinverdire ogni spazio privato, compresi i tetti, con un rinverdimento che per la sua velocità l’amministrazione ha paragonato a uno tsunami di foglie, rami e radici.
Il verde come infrastruttura
Una caratteristica tipica dei progetti urbani di questo tipo è il fatto che gli spazi individuati non sono visti come elementi isolati, ma il “verde pubblico” è considerato una vera e propria infrastruttura unitaria: come quella stradale, deve essere connessa il più possibile, migliorando così la vivibilità di una città e fornendo servizi di resilienza. Vitoria-Gasteiz, nel nord della Spagna, ne è forse l’esempio più scenografico: si distingue per il suo enorme Anillo Verde, una cintura di spazi naturali e zone agricole che come una tangenziale circonda la città, collegandosi con le reti di piste pedonabili e ciclabili (circa 80 chilometri) e aree naturali protette. Questo anello è stato “forgiato” a partire dagli anni ’90, lega 6 parchi e funge da polmone verde per tutti gli abitanti della città basca.
Il verde come partecipazione
Naturalmente è centrale il fatto che un’area verde di una città rafforza il senso di comunità e la coesione sociale. Vale a dire: spesso ragionare su questi spazi vuol dire coinvolgere chi li usa. A Utrecht, nel cuore dei Paesi Bassi, il piano di inverdimento in vigore dal 2014 al 2015 stato chiamato Quartieri verdi ed è un esempio di questo elemento chiave delle nuove progettualità sul verde cittadino. Il piano generale, infatti, si fondava infatti su piani di quartiere, sviluppati e selezionati a partire dalla consultazione degli abitanti delle varie aree cittadine. Utrecht – che è una città per dimensioni paragonabile a Bologna – per risolvere il previsto aumento surriscaldamento urbano ha varato recentemente un ulteriore piano di rinverdimento di 440 ettari (circa 990 campi da calcio) e 60mila nuovi alberi. E anche in questo caso i cittadini sono protagonisti: contemporaneamente al piano di rinverdimento si stanno raccogliendo dati sulla vivibilità dell’ambiente urbano tramite progetti di citizen science.
Il verde come ecologia
Limitare l’aumento di piante e alberi in una città alla sola realizzazione di rifugi climatici naturali è però limitante. I progetti di rinverdimento hanno sì lo scopo di far sì che l’ambiente urbano sia più vivibile in termini di raffrescamento, ma hanno anche altre funzioni, come il miglioramento della qualità dell’aria o la cattura dell’anidride carbonica. E rendono più complesso l’ecosistema urbano, aumentandone la biodiversità e resilienza. A Dortmund, in Germania, ad esempio un progetto di rinverdimento nel centro dell’area urbana si concentra sulla creazione di prati per aumentare la densità e la ricchezza di impollinatori, ossia la biodiversità, un modello proposto anche a Tallin in Estonia, in un’area verde lunga 13 chilometri (la cosiddetta autostrada degli impollinatori) e in altre città europee. Oltre agli alberi – più visibili – l’interesse è quindi anche quello di avere più fiori in città: la rigenerazione di prati fioriti è una tendenza basata sugli sfalci ridotti e che anche a Bologna vanta numerose iniziative.
Foto: Pixnio