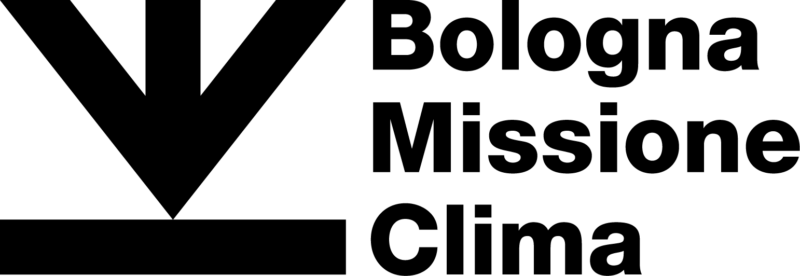Giovedì 29 maggio 2025, l’Auditorium di Filla – Parco della Montagnola – ha ospitato il secondo appuntamento del ciclo di “Esplorando il verde urbano” che, fino a ottobre, approfondirà le sfide e le soluzioni legate al verde nelle città.
L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi insieme al Comune di Bologna per rispondere agli obiettivi di Bologna Verde, un percorso per il rinverdimento della città che prevede attualmente 12 sperimentazioni pilota sul territorio con un finanziamento complessivo di oltre 18 milioni di euro e che, al suo interno, include anche la realizzazione di un programma di attività di carattere educativo, divulgativo e scientifico per approfondire diversi aspetti del verde e della sostenibilità.
Questi 12 progetti pilota, uniti all’impegno della città di Bologna nell’ambizioso percorso della Missione Clima per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, mirano a contrastare gli effetti del cambiamento climatico urbano, una trasformazione urgente e necessaria alla luce dei dati sempre più allarmanti dell’emergenza climatica.
Proprio per questo motivo, in questo secondo incontro abbiamo voluto conoscere e approfondire, grazie all’intervento di esperti ed esperte del settore, i più recenti dati legati al cambiamento climatico e le relative possibili soluzioni al suo contrasto in città.
Dopo un’introduzione dedicata ai progetti già realizzati dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, sono intervenuti gli ospiti:
- Stefano Materia (moderatore), Senior Climate Scientist per il Barcelona Supercomputing Center – Membro del Comitato Scientifico di Bologna Verde;
- Carlo Cacciamani (relatore), Meteorologo e Climatologo, ex-Direttore di ItaliaMeteo;
- Letizia Cremonini (relatrice), Ricercatrice presso l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Bologna (CNR-IBE).
L’emergenza climatica: impatti e rischi
Carlo Cacciamani ha aperto il dibattito sulla necessità di definire la situazione attuale come emergenza climatica piuttosto che come semplice cambiamento climatico.
 Mentre il termine “cambiamento” può dare un’idea neutra o positiva, l’attuale situazione è caratterizzata da impatti negativi già in atto e in continua evoluzione. I dati osservati mostrano infatti un trend di aumento della temperatura, particolarmente accentuato negli ultimi 40-50 anni. Nella zona mediterranea, la nostra, i due principali cambiamenti in atto sono l’aumento della temperatura e gli eventi estremi di precipitazione.
Mentre il termine “cambiamento” può dare un’idea neutra o positiva, l’attuale situazione è caratterizzata da impatti negativi già in atto e in continua evoluzione. I dati osservati mostrano infatti un trend di aumento della temperatura, particolarmente accentuato negli ultimi 40-50 anni. Nella zona mediterranea, la nostra, i due principali cambiamenti in atto sono l’aumento della temperatura e gli eventi estremi di precipitazione.
L’aumento della temperatura non riguarda solo la media, ma sposta l’intera distribuzione verso valori più alti, rendendo temperature considerate estreme in passato quasi normali oggi. Questo si manifesta con l’aumento della frequenza delle ondate di calore ovvero periodi prolungati con temperature massime elevate. Le ondate di calore sono pericolose perché hanno un impatto significativo sulla salute, specialmente per le persone fragili e anziane, con conseguenze economiche per il sistema sanitario. Per questi motivi, richiedono sistemi di allerta e azioni coordinate per monitorare e supportare la popolazione fragile.
Il secondo cambiamento in atto è l’aumento degli eventi estremi di precipitazione che portano alle alluvioni. Ad esempio, è possibile passare rapidamente da situazioni di siccità estrema, come quella che ha caratterizzato l’estate del 2022, a eventi in cui cadono quantità di pioggia equivalenti a mesi in poche ore o giorni, come durante l’alluvione in Emilia-Romagna nel maggio 2023.
Inoltre, è importante sottolineare che il rischio non è solo la pericolosità del fenomeno (caldo, pioggia), ma si determina principalmente quando un fenomeno pericoloso colpisce un territorio vulnerabile ed esposto. La formula del rischio è: R = P * E * V (Pericolosità * Esposizione * Vulnerabilità). Per diminuire il rischio, si può agire su tutti e tre i fattori: ridurre la pericolosità (affrontando le cause del cambiamento climatico, come la riduzione dei gas serra), ridurre l’esposizione (evitando, ad esempio, di costruire edifici in aree a rischio) e ridurre la vulnerabilità (rendendo sistemi e popolazioni più resilienti).
Agire sulla vulnerabilità può avvenire tramite azioni strutturali – come la costruzione di casse d’espansione per le alluvioni -che richiedono tempo e investimenti, o azioni non strutturali – come i sistemi di allerta – che agiscono nel tempo reale.
Le allerte infatti sono fondamentali per salvare vite e ridurre i danni. L’esperienza dell’alluvione in Romagna, dove le allerte rosse hanno permesso evacuazioni preventive, ha limitato le vittime a 17, un numero tragico ma significativamente inferiore rispetto a scenari senza allerta, come accaduto a Valencia lo scorso ottobre 2024. Stimare i danni evitati, ovvero i costi risparmiati grazie alle azioni di adattamento e ai sistemi di allerta (persone salvate, feriti evitati, strutture protette), è di fondamentale importanza. Questi costi evitati dovrebbero essere considerati nel bilancio degli investimenti necessari per l’adattamento. Tuttavia, attualmente, la difficoltà nel quantificare questi benefici rende gli investimenti in adattamento apparentemente troppo elevati, frenando talvolta le decisioni politiche.
Soluzioni di adattamento urbano e la città del futuro
All’intervento di Cacciamani è susseguito quello di Letizia Cremonini che ha illustrato come le pubbliche amministrazioni, e nello specifico il Comune di Bologna, stiano affrontando questa complessità con un approccio strategico e integrato.
 La presenza di tecnici qualificati all’interno dell’amministrazione comunale ha infatti permesso di anticipare le necessità future della città e di strutturarsi internamente con uffici dedicati alla mitigazione e all’adattamento come, per esempio, l’ufficio per la Transizione Ecologica e Climatica.
La presenza di tecnici qualificati all’interno dell’amministrazione comunale ha infatti permesso di anticipare le necessità future della città e di strutturarsi internamente con uffici dedicati alla mitigazione e all’adattamento come, per esempio, l’ufficio per la Transizione Ecologica e Climatica.
Un’azione concreta e innovativa a Bologna è stata poi l’integrazione del piano di adattamento (PAESC) all’interno degli strumenti urbanistici. Nello specifico, l’analisi dei rischi climatici, come le ondate di calore, è stata utilizzata per creare una mappa di fragilità climatica del territorio comunale. In tal senso, questa mappa informa le decisioni di pianificazione e costruzione, richiedendo, ad esempio, che i progetti edilizi (sia pubblici che privati) rispettino specifiche soglie di benessere termico attraverso la scelta di materiali con adeguata riflettività, contribuendo così a mitigare le ondate di calore a livello di singolo lotto.
Un’altra azione molto importante è poi costituita dal rinverdimento della città. Il Comune di Bologna sta quindi realizzando opere di forestazione urbana, selezionando attentamente le specie vegetali non solo per i loro benefici ecosistemici (come la riduzione dell’isola di calore), ma anche considerando l’impatto sulla salute, ad esempio evitando specie altamente allergeniche.
Guardando alla città del futuro, Letizia Cremonini ha sottolineato la necessità di considerare i cambiamenti demografici, in particolare l’invecchiamento della popolazione. La città sarà sempre più abitata da persone anziane, spesso sole, e sarà fondamentale progettare spazi pubblici e servizi che rispondano alle necessità delle fasce deboli (anziani, malati cronici, disabili). Rispondere alle esigenze di questi gruppi garantisce infatti equità per tutti e può ridurre i costi per la sanità pubblica.
L’obiettivo è quindi quello di creare una città dove le persone anziane possano continuare a vivere con dignità, integrate nella comunità, e possano utilizzare gli spazi pubblici in sicurezza anche durante fenomeni estremi come le ondate di calore. Questo richiede un ritorno a modelli sociali che valorizzino il senso di comunità, come dimostrano esperienze virtuose già presenti a Bologna, dove relazioni di prossimità in contesti come i mercati locali servono da rete di supporto informale.
Infatti, affrontare la crisi climatica e costruire la città del futuro richiede un approccio integrato in cui diverse discipline quali urbanistica, architettura, ingegneria, scienze ambientali e sociali collaborano. L’azione di città come Bologna, che integrano mitigazione e adattamento, coinvolgono la cittadinanza e pianificano guardando non solo ai danni da evitare ma anche al benessere e alla dignità delle persone, rappresenta un modello fondamentale per costruire un futuro più resiliente, sostenibile ed inclusivo.
Al termine del dibattito, nell’ottica di favorire il processo partecipativo della cittadinanza ai progetti di Bologna Verde e Bologna Missione Clima, si sono svolte delle tavole rotonde di approfondimento in cui i cittadini presenti hanno potuto confrontarsi con i relatori sui vari temi trattati.
Approfondisci Bologna Verde
Per approfondire il percorso di Bologna Verde è possibile visitare la sezione ad esso dedicata sul sito della Fondazione IU Rusconi Ghigi e su Partecipa – la piattaforma del Comune di Bologna dedicata alla partecipazione dei cittadini, alla collaborazione civica e alla cura dei beni comuni.