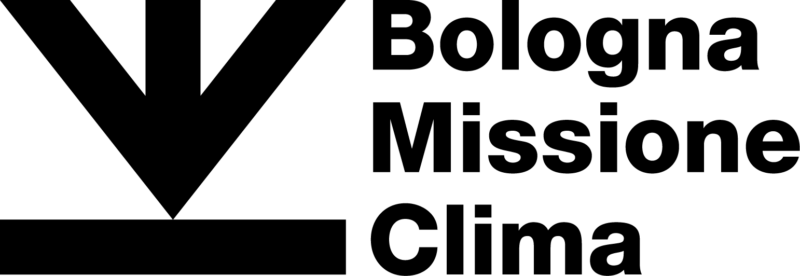Giovedì 12 giugno 2025, l’Auditorium di Filla ha ospitato il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Esplorando il verde urbano“, un percorso che, fino alla fine dell’anno, approfondirà le sfide e le soluzioni legate al verde nelle città.
L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi insieme al Comune di Bologna per rispondere agli obiettivi di Bologna Verde, un percorso per il rinverdimento della città che prevede attualmente 12 sperimentazioni pilota sul territorio con un finanziamento complessivo di oltre 18 milioni di euro e che, al suo interno, include anche la realizzazione di un programma di attività di carattere educativo, divulgativo e scientifico per approfondire diversi aspetti del verde e della sostenibilità.
Questi 12 progetti pilota, uniti all’impegno della città di Bologna nell’ambizioso percorso della Missione Clima per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, mirano a contrastare gli effetti del cambiamento climatico urbano, una trasformazione urgente e necessaria alla luce dei dati sempre più allarmanti dell’emergenza climatica.
Proprio per questo motivo, durante il terzo incontro abbiamo voluto entrare maggiormente nel dettaglio del verde urbano approfondendo così il funzionamento morfologico e fisiologico degli alberi e la loro relativa importanza per l’ecosistema.
Dopo un’introduzione dedicata ai progetti già realizzati dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi nell’ambito del progetto Bologna Verde, sono intervenuti tre esperti del settore:
- Alberto Minelli: Professore e Ricercatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DiSTAL), Università di Bologna, area Parchi e Giardini ed Alberi Monumentali – Membro del Comitato Scientifico di Bologna Verde;
- Luca Corelli Grappadelli: Professore ordinario di Ecofisiologia degli Alberi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DiSTAL), Università di Bologna;
- Francesco Ferrini: Professore ordinario del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università di Firenze.
La gestione degli alberi monumentali: forme, adattamenti, reazioni, difetti
Comprendere gli alberi, la loro forma, i loro adattamenti, le loro reazioni e i potenziali difetti nella loro struttura è fondamentale, specialmente per la gestione degli alberi monumentali. In tal senso, il Professor Alberto Minelli ha aperto il pomeriggio con un intervento di esplorazione della biomeccanica degli alberi, dando risposta, tra le altre cose, a domande quali “cos’è un albero?”, “come funziona un albero?”, “perché un albero cade?”, ”quando un albero ha bisogno di manutenzioni?”.
 Un concetto chiave per comprendere a fondo questo tipo di organismo è che la forma di un albero non è casuale ma nasce dall’ambiente in cui si trova. Gli alberi sono infatti organismi dinamici: le loro chiome si sviluppano nel tempo, mostrando un dinamismo verticale e orizzontale tra estate e inverno. La loro crescita è continua e il nuovo tessuto si crea dove la pianta reputa che sia il momento migliore per risolvere un deficit strutturale. Ogni albero è unico, poiché non esiste una pianta nello stesso posto di un’altra e il luogo determina la sua costruzione.
Un concetto chiave per comprendere a fondo questo tipo di organismo è che la forma di un albero non è casuale ma nasce dall’ambiente in cui si trova. Gli alberi sono infatti organismi dinamici: le loro chiome si sviluppano nel tempo, mostrando un dinamismo verticale e orizzontale tra estate e inverno. La loro crescita è continua e il nuovo tessuto si crea dove la pianta reputa che sia il momento migliore per risolvere un deficit strutturale. Ogni albero è unico, poiché non esiste una pianta nello stesso posto di un’altra e il luogo determina la sua costruzione.
Appurato tutto questo, sarebbe quindi meglio trasformare una domanda apparentemente banale come “perché un albero cade?” in “perché un albero sta in piedi?” proprio per sottolineare l’incredibile capacità di adattamento e reazione di questi organismi naturali. La loro architettura, sebbene “disastrosa” dal punto di vista ingegneristico, è fisiologicamente perfetta e in grado di adattarsi perfettamente alle condizioni in cui si trova. Ad esempio, rami laterali possono assumere un ruolo predominante, diventando la nuova cima dell’albero in seguito a una caduta o abbandono della vecchia. Gli alberi infatti non sono statici; le loro strutture si arricchiscono o impoveriscono nel tempo e alcune parti possono essere abbandonate e cadere, un processo naturale e non necessariamente segno di patologia.
La struttura secondaria di un albero è composta da una parte morta (duramen) e una parte viva (alburno); solo quest’ultima può reagire agli stimoli. Gli alberi non sono mai perfettamente simmetrici ma eccentrici, la loro crescita è stimolata dai difetti che presentano, attivando sistemi di compensazione. Anche l’inserimento delle branche è un processo complesso, con un sistema di fasci che si integra profondamente nel fusto. Tuttavia, in ambiente urbano, gli alberi possono sviluppare numerosi difetti, come la corteccia interclusa (biforcazioni a V o U) o l’inglobamento di elementi esterni che possono comprometterne la stabilità. Il sistema radicale degli alberi, spesso sottovalutato, si concentra nei primi 80 cm di profondità ed è fondamentale per l’ancoraggio e il sostegno.
Come gli alberi percepiscono il proprio ambiente luminoso e cosa significa per noi
Al termine dell’intervento del Professor Minelli, il Professor Luca Corelli Grappadelli ha preso parola spiegando come gli alberi percepiscono e interagiscono con la luce, un’energia fondamentale per la vita sul Pianeta Terra.
 Le piante infatti, a differenza degli animali che sono eterotrofi, sono autotrofe: producono il proprio alimento attraverso la fotosintesi, un processo evoluto nel Precambriano grazie a due eventi di fagocitazione endosimbiontica che hanno dato origine a mitocondri e cloroplasti.
Le piante infatti, a differenza degli animali che sono eterotrofi, sono autotrofe: producono il proprio alimento attraverso la fotosintesi, un processo evoluto nel Precambriano grazie a due eventi di fagocitazione endosimbiontica che hanno dato origine a mitocondri e cloroplasti.
Le foglie agiscono come veri e propri filtri luminosi: assorbono i fotoni (trasformando l’energia fisica in biochimica), riflettono la luce (il verde che vediamo è la radiazione che non interessa alle foglie), la riemettono (sotto forma di infrarosso, ovvero calore, per dissipare l’eccesso di energia) e trasmettono la radiazione elettromagnetica solare. La fotosintesi si articola quindi in due fasi principali: una fase luminosa, in cui i fotoni vengono catturati producendo molecole energetiche (NADPH e ATP), e una fase oscura (Ciclo di Calvin-Benson) che non richiede luce e riguarda la sintesi dei carboidrati. Un eccesso di luce può causare un fotodanno alle foglie, similmente ai danni del sole sulla nostra pelle. Tuttavia, le piante hanno sviluppato meccanismi di difesa, come la modifica dell’orientamento fogliare o la presenza di cere per riflettere la radiazione.
La qualità della luce è altrettanto importante: la fotomorfogenesi (l’origine della forma dipendente dalla luce) spiega infatti come le piante modellino le proprie chiome in risposta all’ambiente luminoso. Questo è visibile nelle interazioni tra alberi dove l’ombreggiamento reciproco può portare alla deformazione delle loro chiome, spingendo i rami a riorientarsi verso fonti di luce bianca (non filtrata) e lontano dalle fonti di infrarosso emesse da altre foglie o da elementi non vegetali, come ad esempio i palazzi. In un contesto urbano gli alberi sono infatti costantemente influenzati dalle radiazioni infrarosse emesse da strade, palazzi e altri corpi scaldati dal sole. Questi segnali luminosi, percepiti dalle piante come calore, possono modificare la forma della chioma spingendola a crescere in direzioni dove riceve luce “buona”. Comprendere questi meccanismi fisiologici è molto importante per una corretta pianificazione urbana e per scegliere quali alberi piantare e in zona.
“Futuro verde”: Soluzioni per quantificare i servizi ecosistemici degli alberi urbani
Con l’ultimo intervento del pomeriggio, il Professor Francesco Ferrini ha evidenziato l‘importanza di misurare il valore dei servizi ecosistemici urbani poiché, senza una quantificazione efficace, i loro benefici rischiano di venir sottovalutati.
 Sebbene la sottrazione di CO2 e la produzione di ossigeno da parte degli alberi siano ormai ben note, il loro contributo su questi due parametri in città è talvolta minimo.
Sebbene la sottrazione di CO2 e la produzione di ossigeno da parte degli alberi siano ormai ben note, il loro contributo su questi due parametri in città è talvolta minimo.
Molti altri benefici sono però fondamentali per l’ambiente urbano, come ad esempio la regolazione del microclima (grazie alla traspirazione e all’evaporazione), la riduzione del rischio di inondazioni e l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico.
Esistono numerosi programmi e modelli per calcolare i servizi ecosistemici in ambiente urbano, ciascuno con specificità diverse. Tra questi:
- InVEST: valuta e mappa servizi come l’assorbimento del carbonio, la depurazione delle acque e la protezione costiera;
- Green Infrastructure Valuation Toolkit (GIVT): si concentra sui benefici economici, sociali e ambientali degli investimenti in infrastrutture verdi;
- OpenStreetMap (OSM) e GIS: usano dati da crowdsourcing e immagini satellitari per analisi spaziali e idoneità dell’habitat;
- R-ECO: uno script R per quantificare e mappare i servizi ecosistemici a livello distrettuale, testato a Copenaghen per identificare carenze;
- SolVES: uno strumento GIS che valuta il valore sociale percepito dei servizi ecosistemici (estetica, ricreazione), mostrando come la vicinanza a specchi d’acqua e percorsi pedonali aumenti tale valore;
- FlorTree: un modello italiano che valuta 220 specie per la loro capacità di rimozione degli inquinanti gassosi (O3 e NO2), basso rilascio di COV biologici (bVOC) ed elevato abbattimento del PM (PM10, PM2.5).
Il modello forse più conosciuto e utilizzato a livello globale è i-Tree Suite (sviluppato dall’USDA Forest Service) che quantifica la copertura arborea, lo stoccaggio del carbonio, il miglioramento della qualità dell’aria e la mitigazione delle acque. Per funzionare correttamente richiede dati dettagliati sull’albero (specie, diametro, altezza, chioma, condizione, posizione), specifiche ambientali (meteo, qualità dell’aria, suolo), dettagli sull’uso del suolo e altri valori socioeconomici (densità di popolazione, valore degli immobili). Nonostante i suoi pro (raccolta dati completa, quantificazione ES, supporto politiche, coinvolgimento pubblico, scalabilità), presenta anche delle sfide (alto impiego di dati, requisiti di competenza, presupposti statici, minore efficacia sui fattori sociali ed economici). Per questi motivi, la ricerca si sta quindi orientando verso l’integrazione di i-Tree con il telerilevamento (LiDAR, immagini multispettrali) e l’intelligenza artificiale per migliorare l’accuratezza e l’efficienza dei risultati ottenuti.
Inoltre, il progetto europeo Life Urban Green ha sviluppato metodologie innovative per la gestione delle infrastrutture verdi urbane, testandole a Cracovia e Rimini. Ha studiato l’efficacia di pratiche come la potatura mirata, l’irrigazione, la decompattazione del terreno e la pacciamatura. Si è scoperto che pacciamatura e irrigazione aumentano la chioma e la superficie fogliare, migliorando i servizi ecosistemici complessivi per l’albero anche se i benefici devono poi essere valutati rispetto ai costi ambientali (es. CO2 dell’irrigazione). Una programmazione dell’irrigazione basata su sensori e bilanci idrici potrebbe così ridurre gli sprechi.
Un aspetto molto rilevante in tutte queste iniziative è il coinvolgimento dei cittadini. Applicazioni digitali come GreenSpaces, iNaturalist, TreeSnap e PlantNet permettono infatti ai cittadini di contribuire con dati su biodiversità e salute degli alberi, aggiornando continuamente le informazioni e supportando la pubblica amministrazione nella gestione ottimale del verde.
Proprio nell’ottica di favorire il processo partecipativo della cittadinanza ai progetti di rinverdimento della città, si sono svolti al termine della conferenza dei gruppi di discussione di approfondimento, in cui i cittadini presenti hanno potuto confrontarsi con i relatori sui vari temi trattati.
Approfondisci Bologna Verde
Per approfondire il percorso di Bologna Verde è possibile visitare la sezione ad esso dedicata sul sito della Fondazione IU Rusconi Ghigi e su Partecipa – la piattaforma del Comune di Bologna dedicata alla partecipazione dei cittadini, alla collaborazione civica e alla cura dei beni comuni.